Perché cerchiamo emozione in un mondo che funziona da solo
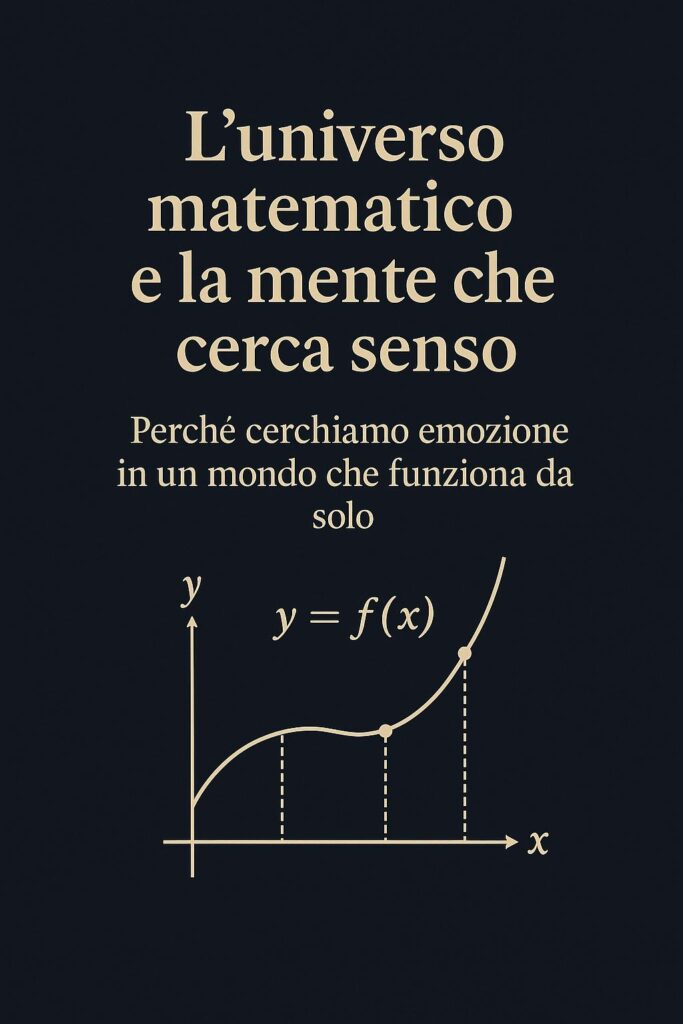
Max Tegmark, nel suo libro L’universo matematico, propone un’idea tanto rigorosa quanto destabilizzante: la realtà non è descritta dalla matematica — è matematica. Tutto ciò che esiste, dalle galassie ai pensieri, è parte di una struttura logica pura, una rete di relazioni numeriche che non ha bisogno di un osservatore per funzionare. In questo quadro, noi non saremmo che formule che si osservano. Ma una formula non prova nulla. Eppure noi sentiamo tutto.
È qui che nasce la frattura centrale della mente umana: vivere in un universo razionale con una coscienza emotiva. La realtà, nella sua struttura profonda, è coerente e indifferente; la mente, invece, non si accontenta della coerenza, vuole significato. Ogni giorno proviamo a umanizzare ciò che ci circonda: un fallimento, un amore, un evento inatteso diventano subito “storie”, perché il cervello ha bisogno di trasformare la logica impersonale del mondo in narrazione. È una strategia evolutiva utile, ma anche la fonte delle nostre rigidità. Quando pretendiamo che tutto torni, quando cerchiamo di forzare la vita in una formula, finiamo per costruire un sistema chiuso dove l’imprevisto diventa colpa, e l’incertezza ansia.
Dal punto di vista psicologico, questo bisogno di coerenza è il modo in cui il cervello cerca sicurezza. Ma la mente, se resta confinata in quella simmetria, smette di crescere. Non tutta la realtà deve “tornare”: alcune parti devono solo essere vissute. Accettare che un frammento resti aperto, che un evento non si spieghi del tutto, è una forma di intelligenza emotiva. È lì che comincia la creatività, la flessibilità, la possibilità di cambiare davvero.
Ogni volta che qualcosa non torna — una decisione, una relazione, un lutto — la mente cerca l’equilibrio dell’equazione: “perché è successo?”, “cosa ho sbagliato?”, “come posso evitare che accada di nuovo?”. È naturale. Ma possiamo provare un gesto opposto: non chiudere il cerchio. Restare per un momento sul bordo della domanda. Non per rinunciare al senso, ma per permettere che il senso emerga, lentamente, da solo. È un modo diverso di conoscere: meno logico, più biologico.
Accettare che l’universo funzioni come una formula non significa negare la libertà, ma riconoscere che la libertà sta nel modo in cui interpretiamo quella formula. Il mondo può essere matematico; ma la mente è umana, e la sua funzione è trasformare la struttura in esperienza, la legge in vissuto, la simmetria in movimento. È questo che fa di noi esseri senzienti: la capacità di abitare un universo impersonale senza smettere di provare emozione.
Forse l’intelligenza, oggi, consiste in questo: convivere con una realtà logica senza pretendere che diventi sentimentale. Saper vedere la formula — e, nello stesso tempo, riconoscere che ciò che la muove, per noi, non è il numero, ma il significato che decidiamo di darle.
“Viviamo in un mondo che noi stessi costruiamo mentre viviamo in esso.”
Humberto Maturana
PRIMO APPUNTAMENTO
GRATUITO
SU WHATSAPP
IN BASSO A DESTRA
I MIEI
CONTATTI
